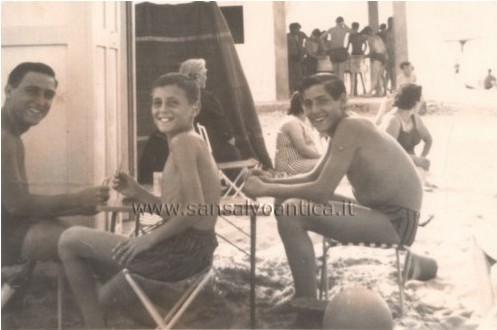Ma chi era quella donna che a me sembrava già anziana e
forse non lo era e che
gne' na mastre anzegnáve?
(come un maestra indicava il da farsi?).
Era
Za’ Vetaléne (Vitalina Torricella 1915 -2007),
sansalvese purosangue, che a ripensarci oggi, senza ombra di
dubbio, può essere definita la prima vera "imprenditrice"
del nostro mare.
La sua storia è quella di una donna d'altri tempi, al passo
con i suoi tempi.
Figlia di
Valérie, così chiamavano Valerio
Torricella, capostipite di un' antica famiglia di
trainìre
(carrettieri), che possedeva nella sua scuderia anche uno
stallone per la riproduzione dei cavalli ed anche, ahimé, un
carro funebre, aveva sposato Michele Colecchia (
mastre
Mecchéle), palatese, falegname, che aveva
la
putéche (il laboratorio) in XIII Corso Garibaldi,
vicino alla caserma dei carabinieri
Donna molto energica, come del resto gli altri componenti
della sua famiglia d'origine,
Za’ Vetaléne
portava, come si suol dire, gonna e pantaloni e sapeva fare
di tutto: svolgeva il classico ruolo di mamma di famiglia,
come tante altre nostre nonne, e sapeva trasformarsi
all'occorrenza anche in artigiana, dando una mano al marito
in bottega. Era lei, ad esempio, a dipingere a mano
fiure
e fiurétte (disegni ornamentali di fiori grandi e
piccoli) sulle sponde
de le trajéne (dei carretti)
ed a richiesta, sopratutto sui carri per i buoi dei
casolani,
a 'rtrattà (a ritrarre)
Sant’Antonie
nghe lu purcàtte e la vaccarélle (Sant'Antonio con il
maialino e la mucca), piccoli ornamenti che a quei tempi
erano una specie di optional, paragonabili a quei portafoto
con la calamita che si appiccicavano sui cruscotti delle
automobili negli anni '60, raffiguranti San Cristoforo,
protettore degli automobilisti, su cui vi erano scritti:
"Vai piano. Sii prudente" o "Proteggi me e la mia famiglia".
Era anche donna molto generosa, così come suo marito
Michele, che nell'immediato dopoguerra ogni tanto le
riportava a casa dei poveri diavoli incontrati per caso,
offrendo loro un piatto di minestra ed un giaciglio, in un
angolo della bottega. Accolsero nella loro casa un pittore
di passaggio, di origini venete, un certo Sor Arturo, il
quale giunto a San Salvo trainando con sé una carriola, non
ripartì mai più, finendo il resto dei suoi giorni nel nostro
paese. Stessa ospitalità diedero a Giovanni, un falegname
napoletano, che fuggito di casa, dava una mano in bottega ad
un ignaro Michele. Fu proprio, lei,
Za' Vetaléne che
lo convinse di tornare dalla sua famiglia, quando un giorno
le si presentò in casa la moglie, che disperata lo cercava.
Era quindi donna di un mondo antico, forte e gentile.
Ma come le era saltato in mente, così all'improvviso, di
mettere quei casotti al mare, quando al mare non ci andava
ancora nessuno o quasi?
Il motivo è semplice e si ricollega ad una nuova mentalità
che negli anni '60, agli albori del boom economico italiano,
investì un po' ovunque il mondo degli artigiani, portandoli
a diventare imprenditori. E' il caso, ad esempio, di molti
frabbicatìure
(muratori), specialmente della vicina Vasto, che
jettarene
la cucchiére da mástre (abbandonarono la cazzuola) per
diventare noti
appaltatìure (titolari di imprese di
costruzione), oppure di molti calzolai che divennero
commercianti aprendo negozi di calzature.
Tornando ai casotti, a dire il vero, l'idea non era sua
,
ma del marito Michele.
Michele, infatti, che come già detto era originario di
Palata ed un po' come tutti i palatesi aveva l’occhio lungo,
era uomo ingegnoso e pieno di iniziative, così come i suoi
tre cugini, Antonio, Giuseppe e Nicolino Colecchia,
muratori, che si erano ficcati in testa di costruire palazzi
nell' ancora deserta marina, idea che si avvererà solo
qualche anno più tardi, quando l'impresa Colecchia ne
costruirà alcuni, tra cui i due dove oggi vi è il Bar Beat
Cafè.
Michele pensò: “Se i miei cugini, muratori, vogliono
costruire le case, io falegname, farò i casotti”.
Ne parlò in famiglia e dopo averne realizzati ben 13 durante
l'inverno, li portò l'estate successiva al mare.
Nacque così, alla marina, un altro "stabilimento balneare",
il secondo dopo quello di Emilio Del Villano.
In realtà più che di uno stabilimento balneare vero e
proprio (a quei tempi non si usava chiamarlo così, ma più
semplicemente
ha messe le casutte a lu muáre - ha
messo i casotti sulla spiaggia), si trattava di una
primitiva forma di attività a conduzione familiare, a cui
partecipavano anche i figli Lillino (Nicola), Venerina e
Beatrice, così come succedeva anche al bar di Emilio, in cui
gli davano una mano la giovane moglie Pina, marchigiana, suo
padre Antonio ed il cognato Donato Corrado, marito della
sorella Antonietta.
1967 - Zia Vitalina, al centro, in primo piano. Da sin.
i figli Beatrice, Lillino e Venerina
Erano quelli ancora i tempi in cui la famiglia, nella buona
e cattiva sorte, era sacra e solidale, così come l'amicizia,
e ci si dava a vicenda una mano.
Forse anche per questo motivo l'arrivo
de Za' Vetaléne
al mare, non turbò più di tanto i sonni di Zio Emilio Del
Villano, che l'accolse con amicizia. I due, infatti,
andavano perfettamente d'accordo anche perché tra loro non
c'era concorrenza alcuna, non essendovi nulla da spartire.
Le due attività, anzi, erano complementari e si integravano
perfettamente tra di loro: Zio Emilio aveva solo il bar e
vendeva le bibite;
Za' Vetaléne, invece, affittava
solo casotti, anche a potenziali clienti di Zio Emilio.
Il fatto, poi, che nessuno dei due affittasse gli
ombrelloni, perché all'epoca così si usava, contribuì a non
creare mai alcuna rivalità tra di loro. Ricordo che Zio
Emilio, l'unico ombrellone che aveva era quello della
pubblicità della Birra Peroni, che la sera rientrava dentro
il chioschetto.
Za' Vetaléne, invece, usava il suo,
personale, al pari dei suoi i clienti.
Insomma i nostri due primi pioneri del mare, andavano, come
si suol dire, d'amore e d'accordo, tant'è che Zio Emilio, al
mattino, con la sua 500 FIAT, spesso dava un passaggio alle
giovanissime Venerina e Beatrice, figlie di
Za' Vetaléne,
perché
Lélline, il figlio maschio, che aveva
comprato anch'egli una 500, era studente universitario a
Bologna ed era sempre fuori sede per motivi di studi.
Sullo sfondo il Bar di Zio Emilio con ragazzini che
giocano al bigliardino. In primo piano, da sin. Vitale
Checchia, Fernando Sparvieri e Franco Germani, figlio
del maestro Aldo, mentre giocano a "asse peja titte"
(asso piglia tutto)..
A sin. il casotto del Maestro Ugo Marzocchetti ed a
destra l'altro del maestro Aldo Germani. La ragazza in
prima fila al centro è Giuseppina Germani, figlia del
maestro Aldo, con due amiche.
Ma come funzionava lo stabilimento balneare di
Za'
Vetaléne?
Tutto funzionava all'incirca in questo modo: io, cioè Zia
Vitalina, ti affitto il casotto e tu ci metti dentro tutto
quello che vuoi. Puoi metterci dentro il tuo ombrellone,
le
costume (i costumi da bagno),
le sìggile a sdraje
(le sdraio),
li sìggilàlle (le sedioline dei
bambini),
lu tragnetèlle,
la pàlàlle e lu
rastrillìcce de le quatréle (il secchiello, la paletta
ed il rastrello dei bambini),
le pajàtte de le grusse e
piccirìlle (le pagliette degli adulti e dei piccoli),
lu materazzéne pe jè fa li bagne e
quàlle che
l'abbotte nghe lu péte (il materassino da mare e la
pompa per gonfiarlo con il piede),
li tamburrélle (i
tamburelli, gioco che tanto andava di moda a quei tempi
sulla spiaggia)... insomma ci puoi mettere dentro tutto
quello che vuoi e che ti può servire per il mare,
nghe
la cumudità (con la comodità, il vantaggio)
de ne
fa sàtte e sàprue (senza doverteli portare sotto e
sopra ogni giorno), come se ti fossi affittato uno chalet
sull'arenile.
Costo stagionale pacchetto completo: £. 20.000 a casotto. In
omaggio
nu banghètte (piccolo sedile in legno), che
però
l'ha da' 'rpusa' (lo devi restituire) a
la
féne de la staggiàune (a fine stagione balneare).
Zia Vitalina, dinanzi ad uno dei suoi casotti, seduta
sopra nu banghette. Dietro di lei, sulla porta
del casotto, la figlia Venerina.
Fu un successone. L' idea si rivelò vincente
Si presero un casotto tutti i signori del paese e non solo.
I loro nomi?
Do’ Marie, il medico, e
donna Lidie
Artese, coniugi,
don Peppine de Véte, altro medico
e
donna Aurore, coniugi anch'essi,
do’ Marie lu
farmaceste (don Mario Di Croce, il farmacista), il
maresciallo Rocco Di Biase, che comandava la stazione dei
carabinieri,
lu mèdeche Tille (dr. Tilli Goffredo),
il medico condotto (così si chiamava all'epoca l'ufficiale
sanitario),
do' Rolande la poste e
donna Marì
Labbrózze (don Rolando Cirese e sua moglie donna Maria
Labrozzi, coniugi anche loro, rispettivamente direttore ed
impiegata dell'ufficio postale),
donna Pije Artese,
appartenente ad una famiglia benestante sansalvese, le
sorelle nubili Delia e Milena Artese, appartenenti
a
chelle de don Pitre (famiglia di Don Pietro Artese),
Leone Balduzzi, commerciante in ascesa.
A questi se ne aggiunsero altri, provenienti da fuori, come
ad esempio un certo signor Bossi, industriale del nord (quel
certo, era molto usato già a quei tempi, quando non si
conosceva l'identità esatta della persona o non la si
conosceva bene), un certo signor Antonio Falciglia, cugino
di
Do' Marie Artese, che si diceva fosse un pezzo
grosso dell’Ufficio delle Imposte Dirette a livello
nazionale, che pare arrivasse addirittura in elicottero
atterrando a Vasto, ed un certo sig. Gino Peroni, riminese,
che nel '63 chiederà la prima licenza edilizia per
realizzare la prima palazzina condominiale su quel desolato
arenile (condominio Peroni), ultimando i lavori nel '68.
Insomma si presero un casotto tutta
la signuruáme (i
signori) del paese, più qualche pezzo grosso forestiero, che
elle ze maffejévene (che sulla spiaggia ostentavano
eleganza).
Il palazzo in costruzione sullo sfondo è stato il primo
edificio condominiale realizzato nella nascente San
Salvo Marina dal sig. Gino Peroni, riminese, che veniva
come turista al mare di San Salvo ed affittava i casotti
da Zia Vitalina. In primo piano il bar di Emilio Del
Villano ed a destra si intravedono alcuni casotti di zia
Vitalina.
L'idea si rivelò talmente proficua che l’anno appresso
Michele, sulle ali dell'entusiamo, durante l'inverno
successivo, ne costruì altri 7 di casotti. Ma questa volta,
purtroppo per lui, non aveva fatto bene i suoi calcoli:
li
signiure z’ave' finìute (i signori erano terminati) e
ave' 'rmise sole le cafìune (ed erano rimasti solo i
contadini) e così i suoi nuovi casotti rimasero
spéccie
(vuoti).
Per niente avvilito, ebbe un'idea: installarli nella vicina
marina di Petacciato, ma anche qui fece cilecca: era
chiù
la 'mpràse che la spàse (era più l'impresa che la
spesa), per cui l'anno dopo se li riportò a San Salvo,
sperando in un incremento demografico signorile.
Quei mosconi andavano a
ruba. I giovani facevano la colletta per farsi un giro su
quei pattini e fare un tuffo al largo. Spesso, tra il
disappunto di Za' Vetaléne, vi salivano sopra più
bagnanti del numero consentito, con qualcuno anche attaccato
dietro, e qualche altro che non sapeva neppure nuotare.
Chissà cosa avrebbe combinato
ancora a quei tempi il signor Michele se non avesse avuto,
per modo di dire, un freno, che erano un po' i suoi figli,
che avevano ben altre aspirazioni nella mente.
In una società che stava mutando, in cui tutti i giovani
cominciavano ad andare a scuola a Vasto per prendersi il
diploma, e si iniziavano ad intravvedere altri tipi di
occupazione, anche i suoi figli avevano ben altro per la
testa e non mostravano, così come tanti altri ragazzi
compaesani, molto entusiasmo nel continuare le attività dei
genitori.
Lilline, che poi diverrà professore universitario,
era studente, sua figlia Venerina faciave la majàre
(aveva aperto a casa uno dei primi laboratori per la
manifattura artigianale delle maglie), Beatrice, l'ultima,
era studentessa in ragioneria a Vasto ed aspirava ad entrare
a lavorare come impiegata, come poi avverrà, alla costruenda
SIV e giustamente... i figli, non avevano molta intenzione
di je' schumue' sanghe a lu mare (di andare al mare
per lavorare). Era meglio andarci solo pe fa' li bbagne
(era meglio andarci per fare i bagni, come normali
bagnanti).
Nonostante i suoi figli, a quanto pare, non credessero molto
nello sviluppo futuro di quella attività al mare, forse
anche a causa di una spiaggia quotidianamente quasi sempre
semideserta, il seme del balneatore, in loro, era stato però
piantato.
Oggi quello stabilimento
balneare, un tempo costituito da soli casotti, è ancora lì
ed è all'avanguardia: il suo nome è IL CORALLO ed è gestito
dagli eredi di Za'Vetaléne e Michele, fatta eccezione
per Lellino, il professore universitario, che vive a Milano.
Eh si! Sono davvero lontani i
tempi in cui al mare non ci andava nessuno o quasi e che Za'Vetaléne
affittava i casotti solo a li signìure (ai
signori), come se fossero dei piccoli chalet in legno, giù
al mare.
Ed a proposito di chalet, una volta successe pure nu
scialàtte (una piccola lite, parola dialettale
sansalvese forse derivante da siparietto o dall'inglese
"piccolo show").
Successe che una famiglia di signori ave' magnate nu
citràune (aveva mangiato il cocomero) e ave'
jttìte li scórcie (aveva buttato le buccie), dinanzi
al suo casotto.
“Ma chi sono questi zulu!", esclamò Lillino, con il suo
raffinato italiano, alla vista di quello spettacolo
indecente.
Apriti cielo. Non l'avesse mai detto.
Si sfiorò l’incidente diplomatico e non solo. Pare che il
cocomero se l’era mangiato una famiglia che si diceva
annoverasse tra le sue fila anche una famosa fattucchiera.
A nulla valsero le scuse e le suppliche de Za' Vetaléne.
Si temette addirittura per l’incolumità fisica del povero
Lillino, a cui, si dice, pare succedessero di notte ed alla
guida della sua auto, cose strane.
Erano davvero altri tempi quelli.
Tra il progresso e credenze popolari.
Tempi belli.
Irrepetibili, come la mia gioventù.